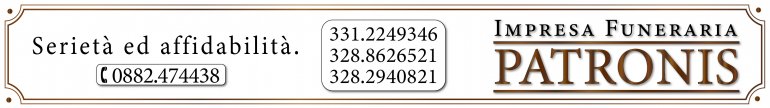Sei tra amici o parenti. D’un tratto ti rendi conto che c’è un’altra persona a portare il tuo stesso nome, poi un’altra ancora.
«Mmèh, putīm’ bbatt’zzà u’ ciucc’», è la prima locuzione che torna in mente ai presenti.
“Battezzare un asino”, o bbatt’jà, come preferivano dire una volta: quando tre persone con lo stesso nome si ritrovano nello stesso luogo, nello stesso momento, è un obbligo da farsi; anche se poi – naturalmente – nessuno va a farlo per davvero.
Da dove prende origine questo detto? E soprattutto, perché proprio un asino? Se lo chiedeva Leo e chissà quanti altri oltre a lui: proviamo a dare una risposta.
L’asino è un animale addomesticato dall’uomo da millenni, fin dall’inizio della storia. Di genere equino (Equus), molto simile al cavallo, è da sempre utilizzato come animale da lavoro e mezzo di trasporto. Preferito al cavallo perché più piccolo e mansueto, meno costoso da nutrire, resistente a portare o trainare grandi carichi e agile nei movimenti su terreni impervi, come tratti di montagna o dissestati, accompagnava l’uomo antico nella vita di tutti i giorni. Col passare dei secoli, causa meccanizzazione dell’agricoltura e spopolamento delle campagne, sempre meno esemplari hanno abitato i nostri fondi.
Basti pensare ad altre frasi di uso comune, come: u’ fan’ fatijà côm’e nu ciucc’, oppure stà car’ch côm’e nu ciucc’ (o nu mûl), per farsi un’idea di quanto lavoro riesca a sobbarcarsi il quadrupede in questione.
Ciucc’, il sostantivo in uso nel nostro dialetto, prende origine dal napoletano ciuccio (o ciucciarjèll’) che a sua volta deriva dal toscano “ciuco”, altro modo di chiamare l’asino nella lingua italiana, oltre a somaro.
Famigerati per la loro ostinazione e testardaggine, nella cultura popolare l’asino non è certo visto come il più intelligente degli animali.
«Jè ciucc’ a la scôla».
«Jè ciucc’, n’sap fa nènd’», e chissà quanti altri modi di appellare il nostro povero equino.
È peraltro considerato simbolo di ottusità e ignoranza. Nei racconti dei nostri nonni, agli studenti più svogliati veniva fatto indossare un copricapo infamante con lunghe orecchie d’asino. Mi viene in mente Collodi e il Paese dei Balocchi e – povero Lucignolo – lui ne sa qualcosa.
Cattiva fama, peraltro, derivata da una cattiva interpretazione: il comportamento di un asino è semplicemente fine al suo istinto di conservazione. È difficile forzarlo a fare qualcosa che sia o gli sembri contraria ai propri interessi. E lo chiami scemo! – mi viene da aggiungere –, ma così è. Che misero destino, gli è toccato pure scaldare Gesù bambino nella mangiatoia!
Dalla credenza popolare secondo cui è duro di comprendonio, nasce la nostra locuzione.
L’origine dovrebbe essere degli alpini. Si dice che avessero un modo tutto particolare per battezzare un asino e fargli memorizzare il proprio nome. Per insegnarglielo, era necessario che più persone pronunciassero insieme il suo nome, accompagnando il tutto da qualche sonora bastonata. La versione corretta, quindi, dovrebbe essere che “tre persone pronuncino lo stesso nome, per battezzare un asino” e non: “tre persone con lo stesso nome, possono battezzare un asino”.
E poi è lui lo scemo!
Come non di rado accade nell’evoluzione della lingua, anche per fatti e aneddoti tramandati oralmente nel corso della storia, si assiste spesso a fenomeni del genere, con significati che si perdono o modificano nella forma, rendendoli di difficile comprensione e interpretazione.
Basti seguire il filo di Arianna per venirne a capo.
La prossima volta che sarete in numero sufficiente per poter “battezzare un asino” quindi, saprete che il necessario non è avere tutti lo stesso nome, ma che tutti pronunciate il suo nome e, che lo impari o meno, è un animale nobile al pari del cavallo e di tutto il creato. Sempre al servizio dell’uomo e, di riconoscenza, considerato pure stupido.
Che adesso stiate pensando ch’rnut e mazz’jât oppure tutt’ ngûl o’ cucuccjâr’, magari di questo ne parleremo una prossima volta.