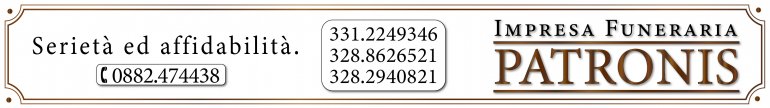Il rosso incandescente dei tizzoni era l’unica fonte di calore nella piccola stanza del vicolo della Terravecchia.
Da tutti era conosciuta come la “chjazza u’ cavut’”, la stradina scoscesa che collegava Seconda Via Terravecchia con Via Campagna degli Orti. In fondo, prima degli ultimi gradoni, uno stretto arco in pietra sormontato da nu uaghj’, segnava il passaggio dal centro storico al paese nuovo, dall’antichità all’era moderna, dal passato al presente.
La chjazza u’ cavut’ è ormai diroccata. I pavimenti delle case riescono a guardare il cielo, senza tetti a ostruire la visuale. L’arco in pietra è murato e la vegetazione si spande incontrollata tra le macerie e le crepe delle vecchie abitazioni. Eppure, poco più avanti sulla destra, alla sommità del vicolo, quasi a guardiano dell’intera strada, c’è ancora una casa ferma nel tempo.
Scioscia ‘Ndina e cummar’ ‘Ndunjétta sono sedute attorno a u’ vrascér’, un fuoco di bivacco domestico. Accomodate sulle sedute impagliate quasi rasenti al suolo, discutono della loro giornata, coi volti rischiarati dalla sola fioca luce rossastra prodotta dai carboni.
«’Ndì, l’a s’nduta a’ tal’visiòn? Dic’ ca n’giama ‘ngaudà cchiù ccuscì. Fa mal’.»
«Marija Verg’n! E com’ jè?»
«E sacc’, dic’ ca r’lascia u’ monoss’d d’ carbonij’. Quédd’, s’ t’u r’spir, fa mal’.»
«U’ cazz’ ca li fréca, s’ nnu métt’ ji lu carbonij’, e mo c’ ppiccia u’ vrascér’! N’ r’lascia prop’t nènd’».
«E k’ n’ sacc’» si congedò ‘Ndunjétta con un sorriso mal celato.
«Com’ jè ca rir’, ‘Ndunjé?»
«Nènd’, scioscia ‘Ndì»
«Uagliò, tu n’ jè ca m’ vuliss’ pigghjà ‘mparzja?» rispose mentre si risistemava il fazzoletto in testa.
Scioscia ‘Ndina aveva la perenne abitudine di risistemare il suo nero fazzoletto, portato in segno di lutto da tempo immemore, dalla scomparsa del marito durante la guerra. La sua immagine non conosceva altro colore all’infuori del nero, oltre al rosa pallido della carnagione.
Sfruttando il momento di distrazione, ‘Ndunjétta si alzò per aprire la porta al gatto. Da qualche minuto reclamava attenzioni per rientrare in casa, grattando ritmicamente sulla porta in legno.
«Dova t’ n’ va, ‘Ndunjé?»
«La vé, jè mm’nuta a’ jattarèdda»
«T’è mm’nuta a’ rattarèdda? Com’ jè tu, quann’ rir’ t’ vé a’ rattarèdda?»
«A’ jattarèdda – ripetè alzando di mezza tacca la voce –, jè mm’nuta a’ jattarèdda! Sta rattann’ la porta.»
«Uagliò, tu t’ n’ bbi’j a jì a’ la mupija. A te t’ vé a raddarèdda e va rratt’ la porta.»
«La vé!» Indicò con l’intero braccio il gatto appena entrato in casa.
Saltellando sulle zampe e la coda ritta come un’antenna alla ricerca di segnale, si piombò spedita verso l’unica fonte di calore che avesse mai conosciuto.
«Sì r’trata, Puscì? ‘Nd fr’cann’ u’ post d’ ‘Ndunjétta ca joj’ n’ tant’ jè ll’ggitt’ma.»
«Pur’? Tu tì la récchja fr’cata e t’ la vulliss’ lu’wà k’ me?» continuò a parlare ancora sull’uscio della porta. «Comung’ mo m’ n’ vaj’, ea fa la cucina, ss’nnò chi tu sènd’ a quidd’!»
«Scin’, camina figghja.»
«K’ t’ada v’dé masséra?»
«S’ n’ m’ vé sonn’, c’ sta nu bèll’ cin’m d’ quidd’.»
«Quidd’ chija jè?»
«Quiddu…Michele Flaccido.»
«Michele Placido» la corresse ‘Ndunjétta in una fragorosa risata. «C’ pò mà chjamà Flaccido?»
«E scin’, com’ jè, n’ jè a’ stéssa cosa?» reagì un po’ stizzita.
«Ma ‘ngap’ a té? Placido jè na cosa, flaccido n’ jè n’auta. Flaccido s’gnif’ca quann’ na cosa jè moscia.»
«E scin’, quidd’ jè fatt’ vécchj’.»
«Mé, buonanott’ ‘Ndì!»
«Buonanott’ ‘Ndunjé!»
S’incamminò verso casa, imboccando strade deserte svanite nel tempo.