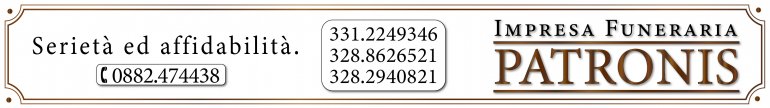I profumi dell’autunno sono i più caratteristici dell’anno. L’odore delle foglie su un tappeto di prato umido, delle caldarroste, degli sbuffi dei comignoli rimessi a regime dopo un’estate di letargo. Anche i colori del cielo diventano più tenui e le ombre sono meno forti. Tutto ti si para davanti agli occhi in punta di piedi, sbiadito, quasi a non volerti dar fastidio. Quando sei bambino queste sensazioni le percepisci di più, sei a stretto contatto con la natura e i suoi mutamenti, ne fai parte.
Nella nostra infanzia questo cambio d’abito di stagione significava l’avvicinarsi della tradizionale calza dei dolci, portata in regalo dai nostri cari passati a miglior vita. Ogni generazione ha vissuto questa usanza a modo suo e ognuno la ricorda come un qualcosa di speciale e unico. Da quando non ci si poteva permettere altro che melograni, noci, cotogni e quant’altro la terra aveva da offrirti, quando le leccornie erano un’eccezione, quando quel poco che avevi in regalo significava possedere il mondo intero.
La mia calza la portava la mia bisnonna, Mammiétta. Così venivano chiamati i veterani di famiglia, mamma e tat’. Il suo vero nome era Maria, da tutti conosciuta come Marietta. Non l’ho mai conosciuta per davvero, tranne che per qualche fotografia scattata dalla memoria quando avevo poco più di un anno, ben impressa e indelebile. Andavo a letto con la speranza di vederla quelle notti, di sbirciare fra le coperte mentre compariva col suo lungo abito nero, fazzoletto in testa, e lasciava il dono che aveva per me sul comodino. Non ci sono mai riuscito.
Tutto questo succedeva quando rientravo a casa dopo un duro pomeriggio di lavoro a chiedere l’anema ‘i morte, con mia sorella e mio fratello prima, con gli amici poi. Le strade erano piene di bambini, ognuno con la sua busta da riempire, ognuno con la speranza di fare bottino. Il primo novembre più suggestivo fu quello con la nebbia. I lampioni sembravano decapitati e le case rimasero senza tetto quella notte. I viottoli della Terravecchia erano ancora più stretti, a quei tempi qualcuno ancora ci abitava; quasi ti abbracciavano i muri segnalati dai ceri rossi poggiati sulle finestre, mentre le canne fumarie facevano il loro lavoro in incognito.
Dopo qualche anno diventi più esperto, sai già quali sono gli obiettivi migliori e dove andare a bussare per recitare la tua filastrocca: «Damme l’anema ‘i morte, ca ‘ssennò te sfasce la porta». In verità non ne ho mai sfasciata una, neanche a quelli che ti cacciavano in malo modo. Le caramelle erano sempre gradite, anche i melograni, se non fosse che te li lanciavano dalla finestra e si spiaccicavano a terra; con una merendina o una barretta di cioccolato facevi cinquina, con un Mars avevi fatto tombola, salvo poi decidere come spartirlo coi compagni d’avventura, ma quando hai dieci anni questi problemi non te li fai, a fine serata ogni busta aveva lo stesso peso delle altre. In via Mercato c’era una signora tanto graziosa quanto generosa, la stessa che mi ritrovai sulla cattedra di Italiano alle medie.
Tutto questo, dal punto di vista dei nostri genitori, dei nostri nonni, era visto come un’abbondanza. Loro riuscivano a racimolare ben poco e quel poco era tanto. La loro calza era una calza per davvero, magari rattoppata. La nostra calza era colorata e aveva il merletto; era una festa altrettanto bella e quanto lo fosse potevamo capirlo soltanto noi. Oggi si pensa che tutto sia diverso, vige la legge del “prima era più bello”, ci sbagliamo di grosso: solo un bambino può sentire veramente quanto sia speciale il suo momento. Crediamo che la nostra infanzia era migliore, coi suoi giochi e le sue usanze, mentre oggi si è perso tutto: non c’è cosa più sbagliata. Era speciale perché era speciale il nostro essere fanciulli, spensierati, desiderosi di scoprire il mondo, di vivere giornate infinite.
Fa rabbia sentirsi minati nelle proprie tradizioni. Non vorrei che un giorno, venendo a bussare alla mia porta, un bambino mi chieda: «Dolcetto o scherzetto?» il 31 di ottobre. Se mai lo farà, la colpa non sarà sua, ma di chi ci tiene così tanto alle tradizioni, tanto da tramandargli quelle di un altro popolo che, per carità, saranno anche belle, ma non sono nostre, sono prive di significato per noi. Se mai verrà a bussare quel bambino, avrà sempre il suo dolcetto, come io ho avuto il mio, dicendogli che se ripassa l’indomani e recita un’altra formula, ne riceverà il doppio.
Cosa facciamo per evitare che le nostre usanze vadano perse? Creiamo catene di disgusto sui social nei confronti di Halloween con la testa abbassata sul telefono, mentre la tivù sta rimpinzando per bene nostro figlio dall’altra parte della stanza.
Qual è il messaggio che stiamo lasciando, che Halloween è la festa del demonio? Quale Dio benevolo condannerebbe un bimbo innocente in cerca di zucchero filato?
Accogliamo il nuovo senza perdere il vecchio.
Lasciamo che i nostri bambini siano bambini, lasciamoli sognare e divertirsi. Non pretendiamo che superino le tappe evolutive senza fatica; per quanto potremmo sforzarci di metterli in una campana di vetro, arriverà il momento in cui avranno un ginocchio sbucciato o stropicciato la coperta. Nel frattempo che crescano, sediamoci accanto e raccontiamogli una storia, loro le adorano, magari raccontiamogli di quella volta in cui siamo rimasti svegli tutta la notte, tentato di sbirciare qualcosa e non ce l’abbiamo fatta.